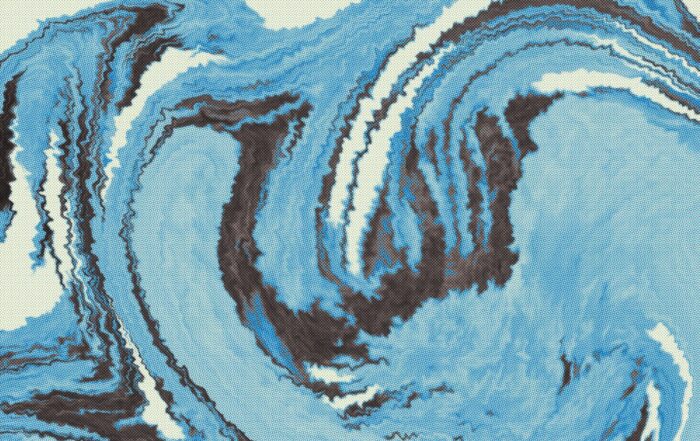A catechismo, o a scuola, siamo stati spesso soggetti alla visione di film sul tema della disabilità, aspirando ad insegnarci l’accettazione del nostro corpo e di quello altrui, la scoperta delle nostre possibilità e l’amicizia.
Purtroppo, è difficile evadere da rappresentazioni limitate allo stereotipo, datate e nocive.
Fu proprio durante una di queste proiezioni che sentii per la prima volta il termine “storpio”. Un ragazzino di circa 12 anni, ai tempi qualche anno più grande di me, veniva assalito da un branco di bulli. In coro, questi gli urlavano “Storpio! Storpio! Storpio!”. Io, seduta in un angolo della stanza buia, guardavo inorridita con gli occhi fissi sullo schermo proiettato, mentre grosse lacrime scendevano dalle mie guance e innumerevoli pensieri scorrevano veloci nella testa.
È questo quello che pensano di me?
È così che le persone mi chiamano, quando io non li sento?
Mi immedesimavo completamente nel bambino, la sua disabilità la sentivo nelle mie ossa, nella mia schiena. I miei compagni accanto a me guardavano con indifferenza la scena, annoiati, contando i minuti per la fine della lezione.
In macchina, prima di tornare a casa, parlai dell’accaduto a mia madre, del film, della parola. Lei arrabbiata e rattristita nel vedermi piangere, si fiondò dalle catechiste, ma ricevette una sola frase di scuse: “non ci avevamo pensato”. Ma infine, nei film che trattano di disabilità, non siamo noi i veri soggetti, ma il nostro impatto sugli altri.
Anni dopo, decisi di buttarmi sugli studi definiti “Disability Studies” e incontrai per la prima volta la parola “crip”. La traduzione italiana, ormai marchiata nella mia testa come un termine dispregiativo e umiliante, la incontrai dopo quella fatidica proiezione innumerevoli volte, ma sempre con le stesse connotazioni.
Questa volta crip portava con sé immagini di una cultura nascosta, una sensibilità esclusivamente disabile e lontana dall’immaginazione distorta degli abili.
Sebbene ancora in gran parte un termine taboo, con il diffondersi dei movimenti per i diritti delle persone con disabilità dagli anni ’70, anche la parola e le sue connotazioni più positive aumentarono in utilizzo, a partire dalla strada fino all’ambito accademico.
“Crip” è la forma abbreviata e informale dalla parola “cripple”, scelta da alcune persone disabili per auto definirsi e attuare una sorta di “riappropriazione”, sulle orme della comunità LGBT con il termine “Queer”.
Mentre “disabile” veniva considerato troppo medico, “crip” traduceva perfettamente il contesto sociale e politico in cui vivevano.
Nell’essay del 1986, “On Being a Cripple”, Nancy Mairs scrive:
Innanzitutto, la questione della semantica. Sono una storpia. Scelgo questa parola per definirmi. La scelgo tra diverse possibilità, le più comuni delle quali sono “handicappato” e “disabile”. Ho fatto la scelta diversi anni fa, senza pensarci, ignara delle mie motivazioni per farlo. Anche ora, non sono sicura di quali siano questi motivi, ma riconosco che sono complessi e non del tutto lusinghieri.
La gente, storpia o no, sussulta alla parola “storpio”, mentre non lo fa con “handicappato” o “disabile”. Forse, voglio che sussultino. Voglio che mi vedano come un soggetto duro, uno con cui il destino/gli dei/i virus non sono stati gentili, ma che può affrontare con decisione la brutale verità della sua esistenza.
Da storpia, spacco.
First, the matter of semantics. I am a cripple. I choose this word to name me. I choose from among several possibilities, the most common of which are “handicapped” and “disabled.” I made the choice a number of years ago, without thinking, unaware of my motives for doing so. Even now, I’m not sure what those motives are, but I recognize that they are complex and not entirely flattering. People–crippled or not–wince at the word “cripple,” as they do not at “handicapped” or “disabled.” Perhaps I want them to wince. I want them to see me as a tough customer, one to whom the fates /gods /viruses have not been kind, but who can face the brutal truth of her existence squarely. As a cripple, I swagger.
Mairs sceglie questa parola “per definirsi”, non per definire la comunità, evidenziando come la scelta di questo termine sia strettamente personale e stia ad ogni persona decidere se si sente “crip”
“Crips supporting crips! Only! Ever! Crip-on-crip support is awesome!”
Nel caso di Care Work: Dreaming Disability Justice, Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha utilizza il termine per parlare di un collettivo, organizzato per persone con disabilità da persone disabili.
Si tratta di riformulare socialmente il significato di ricevere cure ed essere curato, cambiare la narrativa, da passiva ad attiva. Il disabile, o in questo caso “crip” non ha come obbiettivo personale diventare abile o neurotipico, ma combattere contro quelle strutture sociali che gli negano accesso, istruzione, cultura e lavoro.
Gli ostacoli sociali non sono solo analizzati nell’individualità del crip, ma nelle identità multiple che caratterizzano il collettivo. Consapevoli che molti membri, oltre la mancanza di rampe e interpreti, lottano quotidianamente contro razzismo, transfobia, omofobia e sessismo.
Il modello, radicale nella sua struttura e nei suoi obbiettivi, si basa sulla solidarietà, rispetto alla carità abile.
La comprensione mutua fra disabili aiuterebbe a combattere lo stigma attorno la richiesta di aiuto, che per quanto imbarazzante o intima, non sarebbe lasciata incompresa o non già vissuta. La possibilità di raccogliersi fra più persone con disabilità diverse aiuterebbe i “nuovi” disabili ad orientarsi più velocemente, imparando dai disabili “senior” più esperti. Combatterebbe l’isolamento che molti di noi vivono, una solitudine che non ci permette di vedere, effettivamente, le nostre possibilità e che ci indottrina a conferirci valore in base alla nostra produttività.
“Il regalo che ci facciamo a vicenda è percepire ciò che l’immaginazione abile si rifiuta di vedere”
Quest’anno parlai di aver conosciuto, in genuina amicizia, la mia prima persona disabile all’età di 18 anni.
La mia visione della disabilità era limitata e stereotipante quanto quella degli abili, faticavo ad associarmi ad altri disabili sebbene avessi già dentro la stessa rabbia che sento ora.
Pensavo che la vita dovesse essere vissuta in un certo modo, un ideale definito che non va incontro a malattia o dolore, ma alle mie orecchie non arrivava nessuna storia o voce che mi insegnasse un’altra strada.
Essere crip significa comprendere che quel modello di vita non esiste, né per me né per l’abile. È la sua ostinata ricerca che rende la vita noiosa e piatta, non permettendoci di vedere chiaramente come vivere su nostra misura.
Nel mio discorso mi ero chiesta: “Come faccio a capire come vivere, se ogni libro, canzone, film, lezione di storia, si focalizza sulla vita degli abili? Come so io, a ventidue anni, in che direzione andare? Perché mi sembra tutto così dannatamente difficile?”
Collettivo, significa anche questo. A comprendere che non dobbiamo distruggerci, fare il triplo del lavoro o sentire il doppio del dolore per avvicinarci a una vita che non ci ha considerato.
Riguardo a questo concetto Leah Lakshmi tratta di intelligenza crip, un passaggio fondamentale che mi piacerebbe riassumervi.
L’intelligenza crip è comprensione, anche quando i piani non vanno come vorremmo, la supposizione che alcune cose accadono al di là dei nostri desideri. Sapere che il dolore può farci comportare un po’ da stronzi; non dar per scontato la malattia quando non ci presentiamo ad un evento culturale o non scendiamo in piazza. Non pretendere che tutti riescano a partecipare a manifestazioni lunghe chilometri, sotto il sole, perché non è necessario per provare il nostro interesse per la causa.
È adattarsi a nuovi linguaggi e circostanze. Utilizzare termini meno accademici, perché non tutti abbiamo avuto accesso all’istruzione, all’univesità, alle lingue straniere, ma tutti meritiamo di conoscere la nostra storia e cultura.
È comprendere la solitudine, l’isolamento, la depressione, l’ansia. È un’intelligenza non giudicante.
Le mie insicurezze sono state sostituite da concetti che mi accettano per quella che sono. Troppe volte ho considerato un pomeriggio sul divano “procrastinazione”, anche se consapevole che se il dolore mi avesse lasciato stare anche solo un minuto mi sarei fiondata sui libri. Per troppo tempo mi sono sentita in colpa delle mie necessità.
Leggendo Care Work, si è accesa in me la necessità di trovare un collettivo in cui sperimentare i valori di supporto e mutua comprensione descritte nel libro. Approfittando del mio recente trasferimento a Bologna, ho iniziato a cercare studenti con disabilità con voglia di unirsi ad un gruppo che potesse fungere come punto di partenza per porre la disabilità sul tavolo delle tematiche più discusse e lottate dagli studenti universitari.
Una missione difficile, che può sembrare impossibile se non si è circondati da un sistema di supporto funzionante. Dobbiamo educare le masse alla cultura crip, ma anche coloro, come i gruppi studenteschi, che si considerano già educati.
Rifiuto le frasi “siamo ignoranti in materia”, “nessun disabile ha partecipato ai nostri incontri”, se dietro non c’è la comprensione di cosa significhi rendere il proprio attivismo accessibile, inclusivo. Spingo gli abili a chiedere, invece, “come possiamo informarci?”.
Troppe volte ho visto inserito l’abilismo nella lista della spesa di discriminazioni da combattere, per poi essere abbandonato perché richiede troppa auto-critica. L’anti-capitalista teme il disabile perché non sa cosa fare dei nostri corpi. L’anti-colonialista ha difficoltà a staccarsi dalle concezioni colonialiste della disabilità.
La femminista lotta per un’immagine di donna “intera”, di cui la disabilità non ne fa parte. E così via.
Anche e soprattutto nei circoli di disabili, è necessaria la comprensione intersezionale delle nostre identità.
L’intersezionalità secondo i 10 principi di disabilità:
Sappiamo che ogni persona ha identità multiple e che ogni identità può essere un luogo di privilegio o di oppressione. I meccanismi dell’oppressione e il modo in cui influiscono, cambiano a seconda delle caratteristiche di una data interazione istituzionale o interpersonale; la stessa comprensione dell’esperienza della disabilità viene plasmata da razza, genere, classe, espressione di genere, momento storico, relazione con la colonizzazione e altro ancora.
We know that each person has multiple identities, and that each identity can be a site of privilege or oppression. The mechanical workings of oppression and how they output shift depending upon the characteristics of any given institutional or interpersonal interaction; the very understanding of disability experience itself is being shaped by race, gender, class, gender expression, historical moment, relationship to colonization, and more.
di Patty Berne, editato da Aurora Levins Morales e David Langstaff, per conto di Sins Invalid
Compreso questo, una volta formato il collettivo, è necessario utilizzare tutte le nostre risorse per andare oltre la nostra esperienza, e, autonomamente e assieme agli altri, lavorare sullo scoprirci, accettarci ed aiutarci.
“we move together, with no body left behind.”
“Ci muoviamo assieme, nessuno/nessun corpo rimanga indietro”.
From The Others è un progetto partito nel 2021 da tre studentesse e una lavoratrice, ora come ora c’è bisogno di più persone che mai. Se studiate a Bologna, scrivetemi su instagram @sistemabile o nel mio profilo personale @liltinynora